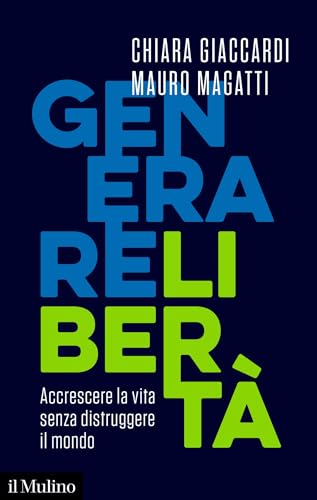Ugo Morelli: Bernard Stiegler, un autore che vi è caro, ha scritto in un suo libro, Pensare, curare, Meltemi, Milano 2024, che la gioia creatrice può provenire solo dalla malinconia. Voi vi occupate in questo vostro nuovo libro di un tema portante della vostra ricerca, la generatività, e lo coniugate con un tema incandescente come la libertà…
Chiara Giaccardi: Proprio nella prospettiva di un orientamento generativo e cercando di fare i conti con questioni molto affini a quelle poste da Bernard Stiegler, abbiamo voluto portare la nostra riflessione sulla soglia della nostra contemporaneità, consapevoli che viviamo un tempo che potremmo definire tempo del limite.
UM: In che senso “tempo del limite”?
CG: Le forme di vita che emergono dal modello di sviluppo dominante ci pongono di fronte al limite delle risorse e della vivibilità. Le pratiche e i rischi distruttivi sono sotto gli occhi di tutti, dalle risorse ambientali essenziali per la vivibilità, alla distruttività umana mediante i processi di negazione, di esclusione e antagonistici, fino alle guerre. Allo stesso tempo è forse proprio nel limite che va cercata l’istanza generativa. Abbiamo bisogno di togliere, nel senso di selezionare l’esistente, al fine di aprire spazi per l’inedito.
UM: E qui siamo sul vostro terreno…
Mauro Magatti: Il concetto di generatività chiama in causa una centratura sull’azione e sulla prassi. Ad essere privilegiata è la prospettiva trasformativa, che accanto a quella critica e analitica ci permette di abitare non solo il passato e il presente ma di perseguire un senso di avvenire. La generatività si propone, quindi, come una delle azioni trasformative che rendono le persone capaci di gestire una libertà che non è consumo individualizzato ma opera relazionale.
UM: Accrescere la vita senza distruggere il mondo, come recita il sottotitolo del libro, si propone come una ricerca della quadratura del cerchio.
MM: Non si può uscire dalla crisi del presente e dai rischi profondi che essa comporta senza accettare una sfida della stessa portata. Quella ricerca assume, perciò, le caratteristiche di una sfida epistemologica e allo stesso tempo operativa, nel lavoro che proponiamo a noi stessi prima di tutto, e a chi intende dialogare con noi. L’assunto di base del nostro libro è il riconoscimento della dimensione eminentemente relazionale di ogni ente e di ogni fenomeno del sistema vivente. Non solo tutto ciò che vive è in relazione ma è necessario riconoscere che non esiste forma di vita che non nasca dalla relazione.
UM: Perché tanta attenzione alla relazione?
CG: La dimensione antecedente e costitutiva della relazione rappresenta per molti aspetti il luogo di tutti i problemi e di tutte le possibilità. A lungo la relazione non solo non è stata considerata, ma è stata ritenuta un accessorio degli enti, una opzione possibile.
UM: E di cosa si tratta, allora?
MM: Riconosciamo sempre più evidentemente che la relazione non è una scelta, e questo libro pone al centro dell’analisi quel riconoscimento, proponendo la relazione come proprietà costitutiva degli stessi esseri viventi e del loro rapporto con l’ambiente e la vivibilità. Possiamo avere almeno due accezioni della relazione. Una è quella che ce la fa concepire come un’interazione fra due soggetti che possono scegliere o meno di essere in relazione. Oggi, grazie a fondamentali scoperte scientifiche assistiamo al rovesciamento del senso del processo: la relazione precede l’individuazione ed è costitutiva della soggettività, in ragione della base comune di carattere corporeo e delle dotazioni neurofisiologiche di cui disponiamo.
UM: Questo fa di noi non degli individui, ma dei condividui secondo il neologismo dell’importante antropologo Francesco Remotti.
CG: Il timbro distintivo del nostro contributo, almeno nei nostri intenti, sta nel chiaro orientamento etico che pone la responsabilità dei modi di vivere la relazionalità a fattore distintivo delle possibilità umane. L’attenzione per la generatività e il senso del possibile caratterizza anche questo nostro lavoro. L’umanità, quindi, è di fronte alla scelta relativa ai modi di abitare la dimensione relazionale del vivente. Se la società è diventata una macchina desiderante, senza per questo aver superato le necessità e i bisogni almeno in parti molto rilevanti dei gruppi umani che vivono sulla Terra, la questione diventa come sviluppare una capacità di vivibilità sostenibile che sia in grado di governare la propria espressione e soddisfazione dei desideri.
UM: E quindi?
MM: Si tratta di cercare le vie per prendersi cura della riproduzione del mondo. Una delle condizioni che individuiamo riguarda la ricerca di un’originale elaborazione dell’opposizione che attraversa le principali questioni contemporanee: tra la pervasività della tecnica e un liberismo senza limiti da un lato, e la regressione nella chiusura nazionalistica e securitaria dall’altro. La sfida principale verso la quale ci impegniamo riguarda la ricerca delle vie per transitare da forme di individualismo e di chiusura indifferente in sé stessi, verso il riconoscimento e la pratica del valore generativo della relazione.